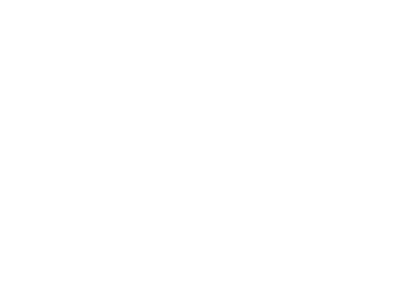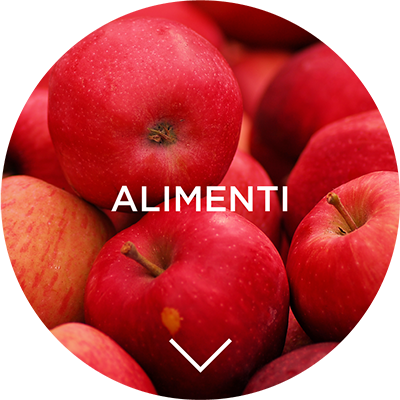Pala V, Sieri S, Chiodini P, Masala G, Palli D, Mattiello A, Panico S, Tumino R, Frasca G, Fasanelli F, Ricceri F, Agnoli C, Grioni S, Krogh V.
Am J Clin Nutr. 2019 Nov 1;110(5):1220-1230
Associazioni del consumo di prodotti lattiero-caseari alla mortalità attraverso l’indagine prospettica europea sul cancro e l’alimentazione (EPIC)- coorte Italia
BACKGROUND:
Il rapporto tra consumo di prodotti lattiero-caseari e salute e mortalità è controverso.
OBIETTIVI:
abbiamo studiato le associazioni di consumo di vari prodotti lattiero-caseari con mortalità nella coorte italiana dell’indagine prospettica europea su cancro e nutrizione (EPIC)-studio Italia.
METODI:
il consumo di prodotti lattiero-caseari è stato valutato mediante validazione FFQ semiquantitativa. I modelli multivariabili di cox stratificati per centro, età e sesso e corretti per tener conto delle associazioni stimate di latte (totale, intero e a ridotto tenore di grassi), yogurt, formaggio, burro e assunzione di calcio da latticini con mortalità per cancro, malattie cardiovascolari e tutte le cause. La non linearità è stata testata con una limitata regressione cubica della spline.
RISULTATI:
dopo un follow-up mediano di 14,9 anni, sono stati identificati 2468 decessi in 45.009 partecipanti: 59% da cancro e 19% da malattia cardiovascolare. Non è stata trovata nei modelli corretti integralmente nessuna associazione significativa del consumo di un qualsiasi prodotto lattiero-caseario con la mortalità. È stata riscontrata una riduzione del 25% del rischio di mortalità per tutte le cause con l’assunzione di latte da 160 a 120 g / d (HR: 0,75; IC al 95%: 0,61, 0,91) ma non per la categoria di assunzione più alta (> 200 g / d) (HR: 0,95; IC al 95%:0,84, 1,08) rispetto all’assenza di consumo.
Associazioni di consumo di latte intero e a ridotto tenore di grassi con tutte le cause e con la causa specifica di morte erano simili a quelli del latte nel suo insieme.
CONCLUSIONI:
In questa coorte italiana caratterizzata da un consumo di latte medio-basso, non abbiamo trovato prove di un’associazione dose-risposta tra consumo di latte e la mortalità e inoltre nessuna associazione tra il consumo di altri prodotti lattiero-caseari esaminati e la mortalità.
Abstract
Associations of dairy product consumption with mortality in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)–Italy cohort
BACKGROUND:
The relation of dairy product consumption to health and mortality is controversial.
OBJECTIVES:
We investigated associations of consumption of various dairy products with mortality in the Italian cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)–Italy study.
METHODS:
Dairy product consumption was assessed by validated semiquantitative FFQs. Multivariable Cox models stratified by center, age, and sex and adjusted for confounders estimated associations of milk (total, full fat, and reduced fat), yogurt, cheese, butter, and dairy calcium consumption with mortality for cancer, cardiovascular disease, and all causes. Nonlinearity was tested by restricted cubic spline regression.
RESULTS:
After a median follow-up of 14.9 y, 2468 deaths were identified in 45,009 participants: 59% from cancer and 19% from cardiovascular disease. No significant association of consumption of any dairy product with mortality was found in the fully adjusted models. A 25% reduction in risk of all-cause mortality was found for milk intake from 160 to 120 g/d (HR: 0.75; 95% CI: 0.61, 0.91) but not for the highest (>200 g/d) category of intake (HR: 0.95; 95% CI: 0.84, 1.08) compared with nonconsumption. Associations of full-fat and reduced-fat milk consumption with all-cause and cause-specific mortality were similar to those for milk as a whole.
CONCLUSIONS:
In this Italian cohort characterized by low to average milk consumption, we found no evidence of a dose–response association between milk consumption and mortality and also no association of consumption of other dairy products investigated with mortality.
Link all’articolo originale: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31435641